con le scarpe tutte rotte.
Il vestito alla romana
viva viva la Befana.
COSì MI DICEVA LA MIA NONNA...
Dal XIII al XVI secolo la Befana non è ancora una persona ma solamente una festa, una delle più importanti e gioiose dell’anno. Nel tardo 1500 si comincia a parlare di Befane come figure femminili che vanno in giro di notte a far paura ai bambini. In seguito la Befana diventa una benefica vecchina che, a cavallo di una scopa, porta doni nella dodicesima notte. Il suo culto si ritrova in varie parti del mondo. In Francia si fa un dolce speciale al cui interno si nasconde una fava. Chi la trova viene nominato Re o Regina della festa. In Spagna i bambini pongono davanti la porta di casa un bicchiere d’acqua e del cibo. In Russia, dove il Natale viene celebrato il 6 gennaio, i doni vengono portati da Padre Gelo accompagnato da Babuschka, una simpatica vecchietta.
La festa assume caratteri diversi nelle varie regioni. In Veneto i ragazzi girano per le case cantando laudi in onore della Sacra Famiglia; in Toscana vi sono le “befanate” rappresentazioni sacre e profane. Befanate sono anche i canti che gruppi di giovani intonano davanti le case per ricevere doni, come accade in Calabria, Sicilia, Puglia e nel nostro Abruzzo.
In Friuli dischi infuocati si fanno ruzzolare sui fianchi delle colline; in Veneto vengono accesi falò per bruciare fantocci raffiguranti la Befana; in Abruzzo si pensa che gli animali parlino ma non bisogna udirli, pena la morte.
C’è inoltre una leggenda comune che spiega la nascita di questa figura “Quando i Re Magi partirono per portare doni a Gesù Bambino, solo una vecchietta si rifiutò di seguirli. Quando, pentita, cercò di raggiungerli, non ci riuscì. Da allora, nella notte tra il 5 e il 6 gennaio, volando su una scopa con un sacco sulle spalle, passa per le case a portare ai bambini i doni che non è riuscita a dare a Gesù Bambino”.
La storia della Befana pone quindi le sue radici all’interno di una tradizione culturale di matrice pagana, di superstizioni e aneddoti magici.Lo stesso periodo natalizio si pone in un momento dell’anno che storicamente era ricco di rituali e usanze legati alla terra, all’inizio del nuovo raccolto e all’idea di propiziarsi fortuna e prosperità nell’anno nuovo.E’ un personaggio che ha colto suggestioni da diversissime leggende e trasposizioni culturali. L’enciclopedia Treccani ne dà la seguente definizione: è per il popolo un mitico personaggio in forma di orribile vecchia, che passa sulla terra dall’1 al 6 gennaio. Nell’ultima notte della sua dimora il mondo è pieno di prodigi: gli alberi si coprono di frutti, gli animali parlano, le acque dei fiumi e delle fonti si tramutano in oro. I bambini attendono regali; le fanciulle traggono al focolare gli oroscopi sulle future nozze, ponendo foglie di ulivo sulla cenere calda; ragazzi e adulti, in comitiva, vanno per il villaggio cantando…in alcuni luoghi si prepara con cenci e stoppa un fantoccio e lo si espone alle finestre…I contadini della Romagna toscana sogliono invece portarlo in giro sopra un carretto, con urli e fischi, fino alla piazzetta del villaggio, ove accendono i falò destinati a bruciare la Befana…Gli studiosi vedono nel bruciamento del fantoccio (la Vecchia, la Befana, la Strega), che persiste un po’ dappertutto in Europa, la sopravvivenza periodica degli spiriti malefici, facendo risalire il mito della befana a tradizioni magiche precristiane…
L’etimologia del nome Befana, è strettamente legato al nome della festa, è una derivazione infatti delle forme dialettali con cui il popolo esprimeva il termine “Epifania”. Il dualismo affascinante che sta sotto alla figura di questa vecchia è forse il motivo per cui non è mai diventata un vero e proprio oggetto commerciale, fatta esclusione per gli ultimi anni. Se San Nicola è un santo protettore, e Babbo Natale un paffuto rubicondo nonnino che accontenta tutti i bambini, la Befana è invece la sostanza femminile pagana di una lunga tradizione rituale contadina. Non porta soldi, e non ha neppure un gruppo di elfi artigiani per fare regali, la Befana tradizionale porta arance, noci, piccoli dolci casalinghi e carbone, ultimamente zuccherato ma comunque carbone, e ci ricorda che dopo le feste si torna a lavorare a “sgobbare” per i frutti del terreno. Non è un caso l’usanza di dire “l’epifania tutte le feste porta via”. Perché è proprio dopo il sei Gennaio che il contadino ricominciava con la nuova semina, che si riprendevano i fervori casalinghi per dar vita ad un nuovo, e si sperava, prosperoso raccolto.











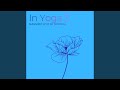



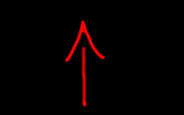



Nessun commento:
Posta un commento